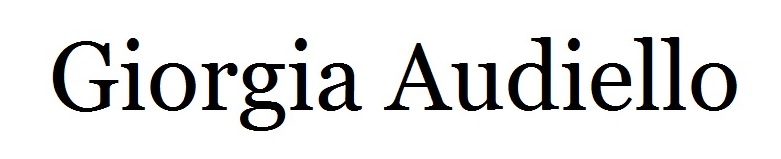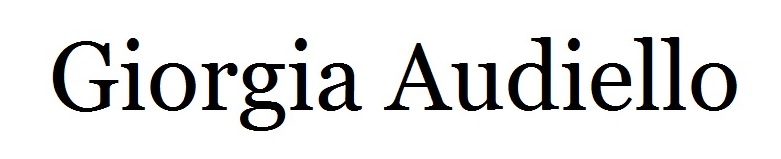La riunificazione di Pechino con Taiwan rappresenta la priorità politico strategica del secolo per la Repubblica popolare cinese (RPC), in quanto costituisce un elemento imprescindibile per riaffermare la grandezza dell’Impero celeste e l’identità storico-culturale cinese dopo il “Secolo dell’umiliazione” (1839 – 1949), durante il quale la Cina è stata dominata da potenze straniere. E Taiwan – detta anche Formosa o Taipei – insieme a Hong Kong, Mongolia interna, Tibet e Xinjiang, fa parte dei territori cinesi storicamente infiltrati da potenze rivali, senza i quali Pechino non può restaurare la grandezza dell’Impero, dopo l’umiliante parentesi della dominazione britannica e nipponica. Per questo, recentemente, il ministro degli Esteri cinesi, Wang Yi, ha affermato che «Taiwan fa parte della Cina. La riunificazione completa della Cina è la tendenza dei tempi e un’inevitabilità della storia. Non lasceremo spazio alle forze indipendentiste di Taiwan o a interferenze esterne».
Così, dopo aver sedato le proteste a Hong Kong e domato le spinte indipendentiste in Tibet e nello Xinjiang, a Pechino non resta che l’ultimo fondamentale tassello per riacquisire lo status di potenza asiatica non solo terrestre, ma anche marittima: l’annessione di Taipei che, d’altronde, è indispensabile al Dragone oltre che per fattori politici interni, anche e soprattutto per fattori geopolitici esterni. Sebbene, infatti, la retorica occidentale ponga la vicenda esclusivamente sul piano della “lotta” tra autarchie e democrazie, essa è assai più complessa e rientra più realisticamente nel contesto della competizione geostrategica tra USA e Cina nell’area dell’Indo-Pacifico, in cui finora ha dominato la potenza a stelle e strisce.
La questione è esplosa in tutta la sua portata in seguito alla visita della Presidente della Camera USA, Nancy Pelosi, sull’isola, che Pechino ritiene una violazione della sovranità della Repubblica popolare in base al principio dell’“Unica Cina”, riconosciuto dagli USA stessi e da gran parte della comunità internazionale: tuttavia, essa covava sotto la cenere da molto tempo, tanto che già Deng Xiaoping aveva affermato, in ossequio all’antica massima di Sun Tzu di “vincere senza combattere”, che «Pechino può attendere la riunificazione per un secolo se necessario». Grazie agli enormi progressi in campo tecnologico-militare portati avanti dallo Stato cinese e all’enorme surplus commerciale del Dragone, pare che quel momento sia finalmente arrivato, presentando il redde rationem di una vicenda storica e geopolitica che affonda le sue radici lontano nel tempo e che ora può determinare un ribaltone nella gerarchia delle potenze sullo scacchiere internazionale: l’isola, infatti, costituisce quello che in geostrategia si definisce un “perno”, ossia un punto nevralgico in grado di spostare i rapporti di forza e la profondità strategica in favore di chi la controlla. La sua annessione alla Cina continentale determinerebbe, inoltre, la definitiva ascesa del “secolo asiatico”, in contrapposizione a quello americano: per questo la lotta degli Stati Uniti per il controllo dell’Indo-pacifico risulta vitale per il mantenimento della residua egemonia globale statunitense e per rallentare l’emergere del mondo multipolare.
L’importanza geografica di Taiwan e la strategia della “catena di isole”
Il dominio dell’Indo-Pacifico – e di Taiwan in particolare – è imprescindibile per il contenimento, da parte statunitense, della RPC nella condizione di potenza terrestre: se, infatti, Pechino rientrasse in possesso del controllo dell’isola si trasformerebbe – ipso facto – in potenza marittima, sfidando la talassocrazia americana e prendendo il controllo delle rotte portanti del commercio mondiale. In tal caso, il Dragone farebbe dell’isola un formidabile scudo a difese delle coste della Cina continentale, dominerebbe i mari cinesi e avrebbe un accesso diretto all’Oceano Pacifico, aggirando così il monitoraggio di navi e basi militari americane dislocate sulle isole del Pacifico. Inoltre, permetterebbe al gigante asiatico di minacciare più efficacemente il Giappone, alleato statunitense nell’area e storico rivale della Città proibita.

Prima e seconda catena di isole
Proprio per evitare tale scenario, gli USA sono ricorsi alla strategia militare della cosiddetta “catena di isole”: elaborata nel 1951, durante la guerra di Corea, dall’esperto di politica estera John Foster Dulles, prevedeva di circondare l’allora URSS e la Cina dal mare, relegandole così a mere potenze terresti. La prima delle tre catene di isole – quella più importante – comincia nelle Curili, comprende Giappone e Taiwan, procede verso la parte nordoccidentale delle Filippine e termina nel Borneo. Taiwan costituisce il centro fondamentale della prima catena e per questo una sua eventuale annessione alla Cina – sfaldando l’intera linea di accerchiamento – farebbe venir meno la stessa strategia di contenimento di Pechino, trasformando il Dragone in potenza marittima e terrestre allo stesso tempo e minando l’egemonia di Washington nella regione.
Le radici storiche della questione di Taiwan
Proprio in virtù della sua centralità strategica, Taipei è da sempre contesa tra la Cina e le potenze rivali. Per arrivare alla questione delle questioni, ossia “di chi è Taiwan”, è necessario, dunque, ripercorrere storicamente gli eventi che hanno portato alla situazione attuale, onde evitare di rimanere intrappolati nella superficiale e a volte alterata lettura dei fatti che ne propone il punto di vista occidentale.
Fin dal Seicento, le potenze europee – in particolare Spagna, Portogallo e Paesi Bassi – tentarono di occupare l’isola. Furono però respinte dall’allora dinastia cinese dei Ming che ne prese il controllo instaurandovi il regno di Tungning. Successivamente, Taipei passò alla dinastia Qing che la trasformò prima in prefettura e dopo in Provincia separata. La Cina perderà il controllo di Taiwan solo nel 1895, quando in seguito alla sconfitta nella prima guerra sino-giapponese, Pechino fu costretta a cedere l’isola a Tokyo. In seguito, con la sconfitta giapponese nella Seconda guerra mondiale, l’isola fu “restituita” alla Repubblica di Cina governata dal Partito nazionalista cinese, il Kuomintang (KMT), fondato e guidato inizialmente da Sun Yat-sen. Nel frattempo, però molti eventi politici sconvolsero la nazione asiatica: nel 1911 cadde il sistema della Cina imperiale in seguito al declino della dinastia Qing. Al suo posto venne istituita la Repubblica di Cina e il Paese attraversò una serie di tensioni interne che sfociò nella guerra civile cinese (1927 – 1950), combattuta tra il KMT guidato da Chiang Kai-shek e il Partito comunista guidato da Mao Zedong.
Inizialmente, il governo nazionale costituito nel 1923 a Canton dal KMT era appoggiato anche dall’allora piccolo Partito comunista cinese nato nel 1921. Successivamente, Kai-shek (succeduto a Sun Yat-sen alla sua morte avvenuta nel 1925) ritenne che l’influenza comunista nel Paese stesse crescendo troppo e nel 1927 ordinò una grande repressione dei comunisti di Shanghai. Ebbe così inizio la guerra civile: dieci anni dopo, nel 1937, i due partiti strinsero un accordo per bloccare l’avanzata giapponese, ma quando Tokyo allentò la pressione militare sulla Cina nel 1941, a causa della guerra che stava conducendo contro gli Alleati e gli Stati Uniti in particolare, il partito nazionalista tornò ad attaccare i comunisti cinesi con l’obiettivo di estirparli definitivamente dal Paese.
A livello internazionale, il partito nazionalista di Chiang Kai-shek era appoggiato dagli Stati Uniti e il presidente Truman lo sostenne con cospicui finanziamenti e forniture di armi, mentre l’Unione Sovietica di Stalin fu molto più cauta nel fornire appoggi al Partito comunista. In ogni caso, il conflitto tra il 1945 e il 1949 volse a favore del partito di Mao Zedong, in quanto quest’ultimo era sostenuto da un forte appoggio popolare, in particolare delle masse contadine a favore delle quali il partito redistribuì i terreni requisiti ai ricchi proprietari terrieri. Nel febbraio del 1949 le truppe comuniste entrarono a Pechino; il primo ottobre, Mao proclamò la nascita della Repubblica popolare cinese, mentre Chian Kai-shek, insieme a circa mezzo milione dei suoi soldati, fuggì a Taiwan scortato dalla flotta americana. Qui proclamò la Repubblica di Cina, sostenendo che fosse la rappresentante legittima del popolo cinese.
La politica dell’Unica Cina e l’ambiguità strategica americana
Da quel momento in avanti, sia la Repubblica popolare cinese che la Repubblica di Cina rivendicavano il fatto di rappresentare l’unica vera Cina: il mondo si trovò quindi a dover scegliere tra due Cine. Sebbene il Kuomintang fosse stato sconfitto e delegittimato dal popolo e dalle masse contadine della parte profonda e rurale del Paese, per diversi decenni gli Stati Uniti non riconobbero la RPC e continuarono a considerare la Repubblica cinese insediata a Taiwan come unico Stato legittimo: su questa base, il seggio all’ONU e nel Consiglio di Sicurezza venne attribuito alla Repubblica nazionalista cinese fino al 1971, quando con la risoluzione 2758 l’Assemblea delle Nazioni Unite decretò la RPC come «l’unico legittimo rappresentante della Cina presso le Nazioni Unite», rimuovendo al contempo i rappresentanti della Repubblica di Cina.
In seguito alla decisione dell’ONU, la maggioranza della comunità internazionale riconobbe la RPC come unica Cina, compresi gli Stati Uniti che con lo storico viaggio del presidente Richard Nixon a Pechino avvenuto il 21 febbraio 1972 – promosso e reso possibile dal “genio politico” di Henry Kissinger – aderirono alla politica dell’“Unica Cina”, riconoscendo la RPC come unico governo legittimo. Durante la «settimana che ha cambiato il mondo» – come ebbe a definirla Nixon – fu firmato un comunicato congiunto tra Cina e Stati Uniti, noto come “Comunicato di Shanghai”. Nel documento vennero sanciti alcuni punti fondamentali: innanzitutto, il riconoscimento dell’esistenza di un unico Stato cinese, rappresentato dalla RPC, con Taiwan parte integrante del suo territorio. In secondo luogo, venne stabilito che né Washington né Pechino avrebbero dovuto imporsi per prevalere nell’area dell’Indo-pacifico, impegnandosi a contrastare una tale propensione nella regione da parte di eventuali altre potenze. Al Comunicato di Shanghai del 1972, seguirono altri due comunicati: quello del 1979 in cui gli Stati Uniti riconoscono Pechino come «l’unico governo legale della Cina» e quello del 1982 in cui veniva ulteriormente ribadito il riconoscimento della RPC come unica Cina, con Taiwan parte integrante del suo territorio.

Gli Stati Uniti avallarono la politica dell’Unica Cina anche nella convinzione che Pechino fosse troppo debole per tentare di riconquistare Taipei attraverso la pressione economica e diplomatica, o direttamente manu militari. Così, puntarono sulla normalizzazione diplomatica con la nazione asiatica in chiave antisovietica, senza prendere in considerazione l’opzione della rapida ascesa cinese a potenza economica e militare.
Allo stesso tempo, la Casa Bianca adottò la cosiddetta politica di ambiguità strategica, in quanto mantenne sempre dei legami diplomatici e militari con l’isola: a tale scopo fu ratificato da Jimmy Carter nel 1979 il “Taiwan Relations Act” con l’intento di supportare in via ufficiosa Taipei. Tuttavia, si tratta di un semplice atto del Congresso USA subordinato al diritto internazionale, i cui contenuti sono volutamente vaghi: Washington si impegna a mantenere relazioni commerciali, culturali e di altro tipo tra il popolo degli Stati Uniti e il popolo di Taiwan, mentre sul piano militare sottolinea che non ha alcun obbligo legale nella difesa dell’isola in caso di attacco. In quest’ultimo caso, sarebbe solo vincolata a fornirgli quanto necessario per difendersi.
L’escalation di tensione tra USA e Cina
Alla luce dei comunicati congiunti e delle relazioni storico-politiche tra la Cina continentale e Taipei, l’esplicito sostegno alle frange separatiste di Taiwan da parte di Washington, nonché la recente visita della rappresentante della Camera USA Pelosi, appaiono non solo come elementi pericolosi ai fini della pace e della stabilità regionale e globale, ma anche come una violazione del diritto internazionale: dopo aver riconosciuto Taiwan come parte della Cina, infatti, gli Stati Uniti stanno alimentando il sentimento anti-cinese nella popolazione locale, facendo leva sulla carta seducente della “democrazia”, così da impedire la riunificazione pacifica dell’isola con Pechino. Dopo aver visto il loro potere d’influenza indebolirsi nei principali teatri geopolitici – a cominciare dal Medioriente che si è smarcato dalle direttive statunitensi come ha mostrato il recente viaggio di Biden in Arabia Saudita – gli USA non possono perdere il controllo dell’area senza vedere interamente frantumata la loro egemonia unipolare, costruita attraverso i più svariati strumenti, tra cui regime change, “guerre umanitarie” e predominio del dollaro: per questo, l’escalation tra USA e Cina appare inevitabile. Sono dunque due i fronti che minacciano l’ordine “globalista-liberale”: quello est europeo in Ucraina e quello di Taiwan nel Pacifico ed entrambi coinvolgono le due superpotenze mondiali in grado di arginare la supremazia a stelle e strisce, stabilendo un nuovo ordine internazionale.
Taiwan e Ucraina: due teatri, una sola strategia
Sia a Taiwan che a Kiev ritroviamo lo stesso determinante attore geopolitico: gli Stati Uniti d’America i quali, in entrambi gli scenari, hanno adottato una strategia simile, fondata su una politica di contenimento che sfrutta due aree legate storicamente e culturalmente in un caso alla Cina, nell’altro alla Russia. Se nel primo caso, il contenimento è stato perseguito via mare attraverso la strategia della catena di isole, nel secondo è stato perseguito via terra attraverso l’espansione a est della NATO, cavalcando i sentimenti nazionalisti di Taipei e di kiev. Il risultato è stato quello di trasformare la prima in un’anti-Cina e la seconda in un’anti-Russia impiegando quelli che sono due perni geostrategici per impedire a Pechino di trasformarsi in potenza marittima e a Mosca in potenza eurasiatica. Sul piano geo-filosofico, il perno corrisponde a ciò che si definisce “luogo del destino”, in quanto ha il potere di imprimere una nuova direzione al corso della Storia. In ambedue i contesti, infatti, la posta in gioco è rappresentata dal cambio di assetti internazionali e dall’ascesa del “secolo asiatico” e né la Russia né la Cina paiono più intenzionate a tollerare le interferenze statunitensi. Per questo, i rischi che i due teatri possano sfociare in un conflitto allargato e dunque mondiale non sono affatto da sottovalutare.
Il ruolo dell’Europa nel conflitto tra USA, Cina e Russia
All’interno di questo precario contesto internazionale, grande assente è l’Europa che non ha alcun ruolo indipendente, in quanto è schiacciata sulle posizioni statunitensi: riprova ne è il fatto che ha immediatamente condannato la recente esercitazione di Pechino attorno all’isola, attraverso un comunicato dei ministri degli esteri del G7, ignorando, di fatto, il principio dell’Unica Cina. Il Vecchio Continente, invece, potrebbe svolgere una funzione fondamentale come mediatore tra Stati Uniti da un lato e Russia e Cina dall’altro, assumendo una posizione equidistante tra le parti in causa. In questo modo non rafforzerebbe solo la sua posizione geopolitica ed economica – seriamente danneggiata dalla politica sanzionatoria impostale da Washington – ma diventerebbe anche un freno sia all’inarrestabile ascesa dell’Eurasia, sia al declinante – ma pur sempre pericoloso – unipolarismo di Washington, in quanto potrebbe imporsi come polo autonomo e strategico dello scacchiere globale: mantenendo le relazioni diplomatiche e commerciali con Mosca, infatti, impedirebbe che quest’ultima consolidi il partenariato con la Cina rallentando così l’emergere dell’“impero asiatico”. Lo stesso Henry Kissinger, del resto, ha affermato che è necessario reintegrare la Russia nel sistema europeo, in quanto è meglio avere una «Russia europea che una Russia asiatica». Allo stesso modo, il più importante statista americano ha asserito che è necessario evitare una guerra con la Cina «che sarebbe catastrofica da tutti i punti di vista». Tuttavia, l’atteggiamento di Washington e del “vassallo europeo” sembra andare nella direzione contraria e Bruxelles, piuttosto che smorzare le tensioni, le acuisce, contribuendo a spingere il mondo verso un pericoloso conflitto. Del resto, il presidente cinese Xi Jinping ha già lanciato il suo avvertimento: «chi gioca col fuoco, finisce per bruciarsi». Nell’Indo-Pacifico si gioca, dunque, una delle partite decisive per le sorti e gli assetti della comunità internazionale, che può segnare l’ascesa definitiva dell’era multipolare, così come il tracollo dell’imperialismo occidentale.
[di Giorgia Audiello]