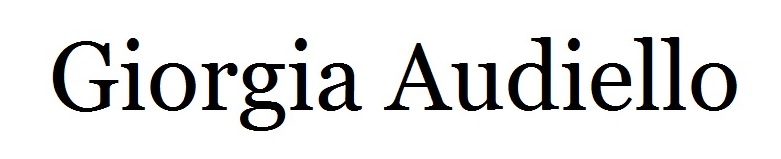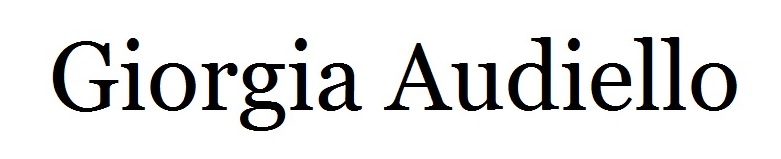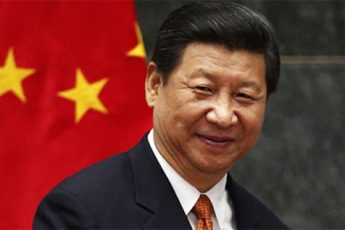Per decenni, la narrazione dominante ha descritto la globalizzazione non solo come un fenomeno rivoluzionario in grado di migliorare le condizioni di vita di milioni di esseri umani in ogni parte del mondo, ma anche come fenomeno inevitabile e spontaneo, sull’onda di quell’entusiasmo ideologico che ha identificato col mito del libero mercato, dell’individualismo e del cosmopolitismo, un automatico e potenzialmente illimitato progresso, il quale a sua volta fonda la sua ragione d’essere sui principi della crescita, della produzione, della scienza e della tecnologia.
In realtà, lungi dall’essere un fenomeno inevitabile, la globalizzazione ha richiesto un processo di realizzazione piuttosto lungo e complesso, con dinamiche che hanno spesso visto i paesi industrializzati in una posizione di forza rispetto a quelli in via di sviluppo, schiacciati dall’egemonia economica e istituzionale dei primi, in un contesto geopolitico squilibrato e alterato a favore delle grandi potenze occidentali.
Gli obiettivi della globalizzazione, vale a dire l’unificazione del mondo in nome del mercatismo e dell’economicismo, sono stati raggiunti nell’arco di svariati anni, attraverso accordi internazionali quali il GATT, i cui negoziati, denominati “round”, diedero successivamente vita all’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC), ma soprattutto attraverso le funzioni svolte dai grandi organismi finanziari internazionali con sede a Washington: Fondo Monetario Internazionale (FMI) e Banca Mondiale.[1] Sono questi ultimi i principali promotori, nonché fautori e custodi di quella logica, nata in seno al liberalismo anglosassone e sviluppata dai cosiddetti economisti “classici”, che predica un fondamentalismo di mercato in base al quale la totale deregolamentazione economica sarebbe in grado di soddisfare, grazie ad un interesse strettamente individualistico, qualunque esigenza della comunità, massimizzando i profitti e contribuendo quindi all’equilibrio economico complessivo. E’ la teoria della cosiddetta “mano invisibile” di “smithiana” memoria, che è stata smentita innumerevoli volte dai fatti e che è diventata il mezzo attraverso cui limitare sempre di più il potere politico, facendo infine di un modello economico distorto uno strumento di colonialismo di seconda generazione, che ha finito per ritorcersi contro i suoi stessi artefici.
Le date che hanno cambiato profondamente non solo la struttura politico-economica del mondo, ma che hanno anche inciso in modo determinante sulla creazione di un nuovo modello sociale, a sua volta globalizzato e dedito al culto del mercato, sono il 9 novembre 1989 e il 15 aprile 1994, sebbene le basi per creare un nuovo ordine commerciale mondiale fossero state gettate fin dall’inizio del dopoguerra con il GATT (Generale Agreement on Tariffs and Trade – Accordo Generale sulle tariffe doganali e sul commercio, 1947).
La prima data, con la caduta del muro di Berlino, ha segnato la fine della divisione del mondo in due blocchi ideologici contrapposti e ha permesso, attraverso processi estremamente rapidi e distruttivi, l’estensione dell’economia di mercato anche ai paesi dell’ex blocco sovietico, grazie al “braccio armato” della finanza anglo-americana: le istituzioni finanziarie internazionali.
La seconda vede invece la nascita, dopo l’ultimo round di negoziati tra i paesi aderenti al GATT, l’Uruguay Round – durato sette anni e mezzo (1986 – 1994) e terminato con gli accordi di Marrakech – dell’Organizzazione Mondiale del Commercio: il tempio del libero mercato, cui sono state subordinate le politiche socio-economiche nazionali e i cui dogmi sono penetrati nel tessuto sociale di un “nuovo mondo” modellato all’insegna di una nuova forma di materialismo storico.
La liberalizzazione del commercio -vale a dire l’eliminazione delle tariffe doganali e più in generale di tutte le misure protezioniste- e del mercato dei capitali sono i pilastri del sistema globalizzato. Ma è fondamentale capire come sono stati costruiti e le conseguenze che hanno avuto, prima sui paesi in via di sviluppo e poi su quelli industrializzati. Sebbene, infatti, la negoziazione degli accordi commerciali internazionali avvenisse nel corso di trattative istituzionali tra i Paesi aderenti al GATT e, in seguito, all’OMC, le istituzioni finanziarie internazionali hanno spesso fatto pressione sui paesi più poveri, affinché liberalizzassero rapidamente le loro economie, quando queste ultime erano ancora fragili e prive degli strumenti necessari per aprirsi alla concorrenza esterna. L’enorme potere dell’FMI, dovuto all’ingente bisogno di finanziamenti da parte di questi paesi, gli consentiva di dettare non solo le politiche economiche, ma anche quelle più propriamente politiche.
“Oggi i mercati emergenti non vengono obbligati ad aprirsi dietro minaccia del ricorso alla forza militare, ma attraverso la potenza economica, con la minaccia di sanzioni o del rifiuto dell’aiuto necessario nei momenti di crisi. […] L’FMI insiste sulla necessità di questa accelerazione come condizione per fornire i propri aiuti, e i paesi che stanno affrontando una crisi capiscono di non avere scelta se non quella di soddisfarne le richieste”.[2]
Naturalmente,
forzare questi paesi alla liberalizzazione dei mercati significava esporli ad
una competizione sproporzionata con le aziende, le banche e le multinazionali
occidentali, che avrebbe (e ha) devastato le loro economie e al contempo ha
favorito le esportazioni e la penetrazione dei mercati e dei sistemi finanziari
locali da parte dei sistemi economici delle nazioni a economia avanzata. Gli organismi finanziari internazionali sono infatti i diretti
rappresentanti degli interessi economici di questi ultimi: non a caso, per
convenzione, il capo della Banca Mondiale è sempre un americano e quello
dell’FMI un europeo.
Il FMI e la Banca Mondiale, insieme all’OMC, compongono quella che può
essere considerata la “trinità” del moderno impianto economico mondialista e le
decisioni economiche della stragrande maggioranza dei paesi del mondo dipendono
dal giudizio e dall’approvazione di queste istituzioni.
Esse infatti:
“[…] sono diventate protagoniste dominanti dell’economia mondiale. Sono tenuti a seguire i loro dettami economici, dettami che riflettono le loro ideologie e teorie neoliberiste, non soltanto i paesi che ne chiedono l’aiuto, ma anche quelli che ne cercano l’approvazione formale per poter accedere più facilmente ai mercati finanziari internazionali”.[3]
Dunque, se da una parte gli organismi internazionali che plasmano l’economia mondiale hanno trascinato, attraverso le minacce, i paesi in via di sviluppo nei meccanismi della globalizzazione, dall’altra, le dinamiche del globalismo hanno progressivamente eroso il potere decisionale degli stati-nazionali industrializzati, conducendo al sopravvento dell’economico sulla sfera socio-politica. Se, infatti, la politica ha mantenuto una dimensione territoriale e locale, l’economia capitalistica, nella sua forma liquida, competitiva e mutevole, si è espansa, travalicando le barriere geografiche e dotandosi di propri strumenti e organismi istituzionali, immensamente più potenti degli stati, non solo per quanto riguarda la risoluzione delle controversie, ma più propriamente per la definizione di nuove regole internazionali.
L’OMC è, in tal senso, uno degli esempi più significativi: qui vengono prese tutte le decisioni che riguardano il commercio mondiale e il suo oggetto non si limita ai beni commerciali, ma è esteso anche ai servizi e alle proprietà intellettuali. Nonostante gli accordi dell’OMC siano vincolanti e sovraordinati rispetto a qualunque legge nazionale, essi vengono negoziati attraverso meccanismi complessi e poco democratici, in quanto solo pochissime nazioni sono davvero coinvolte nelle trattative. Le altre si limitano semplicemente a ratificare accordi che in molti casi sono costituiti da migliaia di pagine.
Dunque, ci si trova in presenza di organismi che sono in grado di produrre nuove forme di regolamentazione, la cui funzione non è più semplicemente quella di normare, nel senso di assicurare ordine e stabilità alle transazioni economiche, ma quella di creare e costruire costantemente nuove leggi (accordi) che si adattino di volta in volta alle esigenze dei mercati. In altre parole, è il diritto che si adatta e si piega all’economia e, con esso, la politica che perde autorità sul suo territorio e assiste, a volte non senza complicità, alla colonizzazione culturale, sociale e politica di colossi stranieri, mentre, di contro, l’economia e la sfera del privato assumono un ruolo decisionale e legislativo che sconfina nel politico, in un capovolgimento dei ruoli che caratterizza tutta la modernità e che determina a sua volta un capovolgimento dei valori sociali.
Se il rapporto tra economia e politica è sempre stato tensivo e concorrenziale, ma bilanciato da una reciproca interdipendenza, con la globalizzazione si è assistito ad un determinante squilibrio a favore della prima e della dimensione del privato, che ha condotto all’egemonia delle grandi multinazionali le quali, non a caso, hanno guidato con forza il processo di unificazione dei mercati e hanno trovato nell’OMC una potentissima “associazione di categoria”, attraverso cui dettare le proprie leggi. La produzione giuridica è sempre più decentrata e frammentata tra una molteplicità di soggetti, che spesso corrispondono a organizzazioni non governative e sopranazionali:
“Il diritto dei mercati viene dunque prodotto sia da soggetti pubblici, sia da soggetti privati. Nel primo caso si può trattare di trattati internazionali o decisioni prodotte da soggetti sovranazionali o infranazionali; nel secondo caso a produrre diritto possono essere le cosiddette transnational corporations, nonché altri possibili soggetti privati a carattere professionale, o istituzioni economiche sovranazionali o infranazionali, o altre nongovernmental organizations”.[4]
Tutto ciò ha condotto ad una vera e propria dittatura delle multinazionali, che ha plasmato un tessuto sociale disgregato di meri consumatori e che ha finito per indebolire le economie locali degli stessi Paesi occidentali: l’enorme potere che ha accumulato il capitale transnazionale, gli ha concesso un peso contrattuale sproporzionato rispetto a quello di lavoratori e sindacati (dove ancora esistenti), consentendogli ad esempio di minacciare il trasferimento della produzione in paesi con un costo della manodopera decisamente più basso. Ciò significa che la globalizzazione ha consentito un ribasso dei salari, dovuta alla competizione tra i lavoratori dei paesi industrializzati e quelli in via di sviluppo, con un notevole svantaggio per i primi, costretti ad accettare paghe più basse e condizioni di lavoro peggiori. In sintesi, la globalizzazione non ha uniformato le condizioni di vita della popolazione mondiale, estendendo i diritti e le conquiste dei paesi “avanzati” a quelli in via di sviluppo, ma adeguando gli standard di vita di questi ultimi ai lavoratori e alla classe media dei paesi di tradizione liberale.
Le stesse industrie locali dei paesi avanzati sono state schiacciate dalla concorrenza spropositata con le multinazionali e spesso costrette a chiudere. Si spiega così ad esempio la deindustrializzazione di molti paesi europei.
Come si evince sia dall’analisi delle origini che dai successivi sviluppi, la globalizzazione non solo ha infranto le sue promesse, ma le sue stesse condizioni di realizzazione sono state costruite sfruttando e impoverendo interi Paesi “emergenti” e hanno finito per indebolire la sovranità di quelli occidentali.
Questo sistema che ha unificato il mondo in nome della libera circolazione delle merci, del profitto e dei capitali ha subito negli ultimi anni un progressivo indebolimento che è culminato con le politiche antiglobaliste di Trump e che sta causando squilibri geopolitici di notevole entità.
Il sostanziale fallimento di questa architettura economica, che è in realtà un mezzo di potere e di controllo, mette in luce la fragilità di un modello antropologico che si basa sui miti e sulle finzioni. Il mito della globalizzazione, infatti, non è stato nient’altro che un grande inganno con cui sono state irretite le masse dei paesi industrializzati, che hanno potuto permettersi il lusso di beni superflui e l’agio di una vita standardizzata, ma che hanno perso il contatto con la loro essenza più autentica, con le loro reali esigenze e hanno visto la loro libertà frantumarsi a causa di bisogni indotti e di un livellamento culturale sempre più sbilanciato verso un degrado sociale e intellettuale, portato avanti soprattutto attraverso la potenza pervasiva dell’intrattenimento hollywoodiano e più in generale “americanocentrico”.
La vulnerabilità di questo sistema, caratterizzato da un estremo squilibrio nella distribuzione delle risorse e dalla predominanza assoluta dell’economico sulla sfera politico-sociale, lo sta portando sempre più rapidamente all’implosione, per imboccare strade alternative che non sappiamo ancora dove condurranno un mondo che ha abbandonato il sacro per inseguire il benessere e i postulati della scienza, ritrovandosi però, suo malgrado, sempre più in balia dell’incertezza.
[1] Per ulteriori approfondimenti sulle origini e le finalità delle Istituzioni Finanziarie Internazionali si veda, su questo blog, l’approfondimento al seguente link: https://www.giorgiaudiello.it/origini-e-finalita-delle-istituzioni-di-bretton-woods-dal-cfr-alleconomia-mondiale/
[2] Joseph E. Stiglitz, La globalizzazione e i suoi oppositori, Einaudi editore, Torino, 2002, p. 61.
[3] Ivi, p. 16.
[4] Maria Rosaria Ferrarese, Le istituzioni della globalizzazione. Diritto e diritti nella società transnazionale, Il Mulino, Bologna, 2000, p. 60.